"Anche Regione e Provincia devono esercitare il loro ruolo di indirizzo per le sorti dell’ex Ilva"
L'intervento dell'ex consigliere provinciale Paolo Chiarenza e del sindaco di Valdieri Guido Giordana insieme ad altri lettoriRiceviamo e pubblichiamo.
Egregio direttore,
anche Regione Piemonte e Provincia di Cuneo devono esercitare il loro ruolo di indirizzo politico-economico per le sorti dell’ex Ilva (già ex Finsider) di Taranto, il più grande centro siderurgico d’Europa, non fosse altro per lo stabilimento di un certo rilievo che c’è a Novi Ligure e per quello seppure più modesto di Racconigi. La sua lunga storia è un’ordinaria follia italiana, costellata di crisi produttiva, di licenziamenti e cassa integrazione, di contestazioni ambientali, di insicurezza sanitaria e di cause giudiziarie, che hanno condotto oggi all’estrema incertezza della continuità di produzione dell’acciaio e a gravi conseguenze economiche e sociali che investono decine di migliaia di lavoratori degli stabilimenti e dell’indotto.
Siccome ieri, oggi e domani dell’acciaio, emblema dello sviluppo industriale, non si può fare a meno, pur consapevoli delle alternanze cicliche del mercato che possono durare anche qualche anno, è necessaria una soluzione per il lungo termine nell’interesse nazionale. L’Italia è in buona parte dipendente dall’estero per l’energia, se lo diventasse anche per l’acciaio sarebbe la fine del traguardo di essere tra le nazioni più industrializzate.
Per scuola di pensiero economico la Destra politica ritiene che quando un’impresa privata varca certi limiti dimensionali, strategici e di impiego di lavoratori, non è più di fatto un’impresa privata, ma un’impresa che va considerata pubblica. Sarà strettamente privata l’impresa dell’artigiano, del coltivatore, del libero professionista, ma quando un’impresa controlla milioni di danaro e dà lavoro a migliaia di persone, non è possibile pensare che la sua esistenza produttiva sia un affare privato dei dirigenti dello stabilimento e degli azionisti di quell’azienda.
Negli anni Novanta del secolo scorso, con Romano Prodi alla presidenza dell’IRI , si avviò la stagione delle “privatizzazioni”, con la svendita delle aziende di Stato. Ma non fu una soluzione risolutiva e in generale vantaggiosa. In più, pur di entrare nell’area della moneta unica (l’euro), venne alterato il nostro modello di sviluppo sacrificando, nello stesso tempo, la siderurgia e l’agricoltura. Da qui, la lunga crisi dell’industria dell’acciaio, che ha visto prima la chiusura del centro siderurgico di Bagnoli in Campania, e poi il difficoltoso processo di privatizzazione dell’Ilva (ora Acciaierie d’Italia) che si trascina come un dramma da allora. Infatti, in tutti questi anni - dal 1995 – si sono succeduti ben 17 governi nazionali, con accordi traditi, miliardi sprecati, investimenti mancati, manutenzione antiinquinamento inesistente, decarbonizzazione drastica antiproduttiva, nessuna decisione in merito all’utilizzo di rigassificatori e inceneritori (come avviene all’estero).
Non rimane che il presidente del Consiglio Meloni e il ministro delle Imprese Urso affrontino risolutamente il nodo della nazionalizzazione del gruppo siderurgico. Sappiamo che nazionalizzare quegli impianti potrebbe costare – secondo gli esperti – anche 10 miliardi di euro, circa un terzo di una legge di Bilancio: una cifra che comprenderebbe il sostegno a tutti i lavoratori (compreso quelli in cassa integrazione), le opere di bonifica e l’avvìo dello sviluppo industriale. Però al contrario, se l’ex Ilva chiude, l’Italia perde una produzione di base, indispensabile alla sicurezza strategica. Ma non solo, ci saranno circa 15.000 lavoratori (compreso quelli dell’indotto) da mettere in cassa integrazione per dieci anni: un peso economico impressionante, una bomba sociale pericolosa. Si tenga conto che l’intervento statale nel risanamento delle imprese incontra il divieto di aiuto di Stato da parte dell’Unione Europea, ad eccezione delle nazionalizzazioni.
In questo complesso contesto, in questo confuso periodo di transizione è infine politicamente strumentale l’accusa del redivivo sindacato CGIL al governo Meloni di “inaccettabile silenzio” e di “responsabile della crisi della politica industriale italiana”. La vera questione è che non si vuole credere nella imprescindibile rinascita del polo siderurgico di Taranto: una questione che riguarda tutto il settore industriale italiano.
Grazie per l’attenzione, distintamente.
Paolo Chiarenza (ex dirigente sindacale), Guido Giordana (sindaco di Valdieri), Luca Ferracciolo (operaio Borgo San Dalmazzo), Mario Franchino (pensionato Beinette)
c.s.
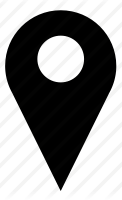 RACCONIGI
RACCONIGI Racconigi - Ilva
commenti
Effettua il login per commentare
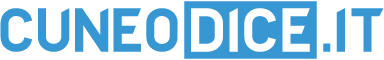

 Condividi
Condividi