Michela Ponzani al Ponte del Dialogo: come un lutto privato diventa memoria collettiva
Alle Fosse Ardeatine non ci furono figure femminili tra le vittime, ma furono loro a custodirne il ricordo. Con “Donne che resistono” l’autrice vuole restituire dignità al loro doloreÈ stata una lezione di storia o una lezione di etica quella tenuta da Michela Ponzani ieri sera al Ponte del Dialogo di Dronero? Entrambe, verrebbe da dire. Da un lato i documenti, le testimonianze, le fonti; dall’altro il dovere etico dello storico, ma anche di ogni cittadino, di trasformare i racconti, quelli veritieri e non le ricostruzioni bizzarre e fantasiose dei nostalgici, in memoria collettiva.
“I fatti sono andati così. I fatti sono andati così” ripete più volte Michela Ponzani in chiusura della serata. “Chi dice il contrario deve dimostrare che non siano andati così, deve produrre documenti, fonti verificabili. Ma non possono farlo, perché la loro ricostruzione è infondata: è un falso storico”. Ma partiamo dall’inizio. La storica e divulgatrice, volto noto del mondo accademico e televisivo, è stata ospite ieri, giovedì 6 novembre, del festival di Dronero per presentare il suo libro Donne che resistono. Le Fosse Ardeatine dal massacro alla memoria 1944-2025.

Le Fosse Ardeatine
Il 24 marzo 1944 Roma fu teatro di uno dei capitoli più bui della sua storia: l’eccidio delle Fosse Ardeatine. In risposta all’attentato partigiano di via Rasella, in cui il giorno prima erano stati uccisi 33 soldati tedeschi, i nazisti organizzarono una rappresaglia feroce e immediata. L’ordine era chiaro: dovevano essere ammazzati dieci italiani per ogni tedesco morto.
Le vittime della strage furono 335 uomini che nulla avevano a che fare con l’attentato di via Rasella: furono scelti tra prigionieri politici, antifascisti, ebrei e semplici cittadini rastrellati a caso. A collaborare nella compilazione delle liste furono anche funzionari fascisti italiani. Nessun avviso, nessuna possibilità di scampo: solo la fredda logica della vendetta.
I prigionieri furono condotti nelle cave di pozzolana lungo la via Ardeatina, allora alla periferia di Roma. Dal primo pomeriggio fino a sera inoltrata, a gruppi di cinque, legati, vennero fatti inginocchiare e colpiti alla nuca uno dopo l’altro.
Ad un certo punto non c’era più spazio per i cadaveri e l’ufficiale Kappler ordinò che le esecuzioni successive venissero compiute sopra i corpi già ammassati, sviluppando i mucchi in altezza. Terminate le operazioni, i tedeschi sparsero spazzatura per coprire l’odore e fecero esplodere gli ingressi per nascondere le prove del massacro.
Donne resistenti
Con il suo libro Michela Ponzani offre una prospettiva inedita su questa tragica vicenda: il punto di vista delle donne. Quelle madri, mogli o figlie che da un giorno all’altro non seppero più nulla dei loro cari. Nessuna risposta, infiniti interrogativi.
“Sono le donne a conservare la memoria” risponde Ponzani quando Gigi Garelli, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, le chiede come mai abbia scelto di dedicare il suo libro alle donne, considerando che tra le vittime dell’eccidio non ci fu nessuna figura femminile. Garelli osserva come nel volume non si parli tanto di donne partigiane o combattenti, domandando che tipo di resistenza abbia trovato in loro.
“Sono donne coraggiose che hanno saputo resistere — risponde Ponzani — e resistere non significa solo impugnare un’arma, ma anche sostenere le scelte di un marito partigiano, affrontare la paura quando la polizia entra in casa e ti minaccia di stupro davanti ai figli, avere la forza di essere la compagna di un uomo che combatte nella Resistenza. È resistere anche dopo la guerra, forse ancor di più, quando a venticinque o ventisette anni sei già vedova, quando nessuno vuole assumerti, quando ti dicono che non sei in grado di crescere i tuoi figli mentre affronti un lutto insopportabile. È resistere presentandosi ai processi per guardare in faccia gli assassini, custodendo la memoria del massacro per i propri figli e per le generazioni future. È resistere pretendendo che le vittime abbiano una sepoltura degna, proprio nel luogo in cui furono uccise. Che a ogni corpo venga dato un nome”.

Il libro
Nel corso della serata Ponzani racconta come la strage delle Fosse Ardeatine abbia segnato la sua vita, al punto da farne la sua tesi di laurea in lettere all'Università di Roma “La Sapienza” e poi continuare a indagare, ascoltare, consultare documenti e proseguire la propria ricerca per altri vent’anni.
“Ho ascoltato testimonianze così strazianti, mi sono talmente immersa nel magma di questo dolore, da dover lasciare decantare tutti questi racconti e queste emozioni prima di riprenderle in mano per scrivere questo libro”.
Il legame di Michela Ponzani con le Fosse Ardeatine nasce quando aveva solo sei anni, grazie ai racconti di suo nonno, entrato nella Resistenza a soli quindici anni e sopravvissuto al bombardamento di San Lorenzo del 19 luglio 1943.
“Mio nonno mi raccontava di quel Mausoleo e mi ci portava in visita. Mi ricordo che partivamo con la sua macchina dell’epoca, sempre con un garofano rosso da portare come omaggio. Mio nonno, in quella strage, aveva perduto uno dei suoi più cari amici: il medico del quartiere San Lorenzo, il dottor Manlio Gelsomini, che non era stato solo un medico capace di curare gratuitamente gli abitanti del quartiere, ma anche uno dei capi delle formazioni di Bandiera Rossa, arrestato per colpa di una spia, portato via, orribilmente torturato e massacrato alle Fosse Ardeatine”.
Quando i testimoni non ci saranno più
Ma cosa succede quando vengono a mancare le testimonianze dirette, quando non ci sono più le persone che hanno vissuto quei momenti a raccontarli? “Si dice sempre che, quando l'ultimo testimone non ci sarà più, sarà molto difficile riuscire a ricordare, a vivere e a sentire con la stessa partecipazione empatica dei testimoni diretti quelle vicende. Questo è vero, ma è anche vero che noi storici abbiamo da questo momento in poi un compito ancora più importante: non solo quello di non disperdere la memoria in un Paese che soffre di cattiva memoria, ma di fare della buona storia, attraverso le fonti, andando a decostruire le mistificazioni, i miti e le manipolazioni del passato sempre presenti nel discorso pubblico. Oggi più che mai, non solo su questo tema, ma su tanti altri”.
Davanti alla platea attenta e raccolta del teatro Iris di Dronero, Michela Ponzani si è soffermata a lungo su questo aspetto.

Fake news e falsi storici
“Il falso storico per eccellenza, un esempio di come si costruisce una falsa notizia al punto che ancora oggi si arriva a fare il processo alla Resistenza, è la storia del manifesto. La teoria secondo cui si sarebbero cercati i responsabili di via Rasella è un clamoroso falso storico”.
“Gli storici lo hanno dimostrato con l’analisi critica delle fonti. Ci furono riunioni in cui i carnefici e gli stessi esponenti fascisti discutevano su quali comunicazioni dare alla stampa. ‘Come potremo rinsaldare la fiducia verso i tedeschi? Diremo che noi i responsabili li abbiamo cercati’. Lo stesso Kesselring lo conferma durante il processo: quello dei manifesti è un falso”.
Nel corso della serata Michela Ponzani ha poi elencato una lunga serie di episodi in cui rivisitazioni e false narrazioni della storia hanno cercato — e ancora oggi continuano a cercare — di colpevolizzare le vittime stesse, stigmatizzando la Resistenza, diffamando, ridicolizzando e umiliando chi invece avrebbe dovuto essere onorato e ricordato come simbolo di coraggio e libertà.
“Il compito degli storici non è solo quello di pubblicare un saggio, ma di smontare le false notizie, le false narrazioni, attraverso ricerche analitiche delle fonti. Dobbiamo uscire dall’accademia e intervenire nel dibattito pubblico, anche per far fronte a bizzarre rivisitazioni nostalgiche” ha concluso.

Nel video qui sotto l'intervista a Michela Ponzani.
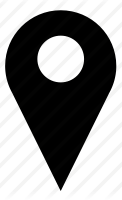 DRONERO
DRONERO Resistenza - Fosse Ardeatine - Ponte del dialogo - Michela Ponzani - Donne che resistono
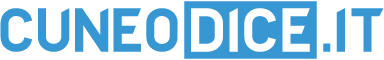





 Condividi
Condividi