"Un dovere ricordare chi combatté, ma anche chi sostenne lo sforzo bellico con resilienza giornaliera"
L'orazione della dottoressa Anna Grillini, del Dipartimento di Studi storici dell'Università di Torino, a Cuneo per le celebrazioni del 4 novembreRiportiamo integralmente il testo dell’orazione scritta dalla dottoressa Anna Grillini, Dipartimento Studi storici – UniTO, per la celebrazione della Festa dell’Unità nazionale e la giornata delle Forze Armate che si è celebrata questa mattina, 4 novembre, a Cuneo.
Nel ringraziare per l’invito a essere qui con voi oggi, in occasione del 107° anniversario della Vittoria nella Prima guerra mondiale e nella giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, saluto le autorità presenti, il Sig. Prefetto, la Sindaca e la cittadinanza tutta.
“Una vita sconosciuta si mostrava improvvisamente ai nostri occhi. Quelle trincee, che pure noi avevamo attaccato tante volte inutilmente, così viva ne era stata la resistenza, avevano poi finito con l’apparirci inanimate, come cose lugubri, inabitate da viventi, rifugio di fantasmi misteriosi e terribili. Ora si mostrano a noi, nella loro vera vita…Il nemico, il nemico, gli austriaci, gli austriaci! …Ecco il nemico ed ecco gli austriaci. Uomini e soldati come noi, fatti come noi, in uniforme come noi…".
Con queste parole Emilio Lussu, autore di una delle più note testimonianze della Grande Guerra ed eminente esponente della resistenza e della politica del dopoguerra, descrive la scoperta dell’umanità del nemico, una rivelazione che accomuna molte testimonianze di veterani e che restituisce a noi la dimensione disumanizzante della Prima guerra mondiale.
Oggi, 4 novembre, è il giorno in cui celebriamo la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, ricordiamo anche l’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti che concludeva ufficialmente il primo grande conflitto del XX secolo. Una guerra senza precedenti che lasciò sul campo 10 milioni di morti e altri 10 milioni feriti e invalidi. Il 12% dei caduti era sotto ai vent’anni e il 60% tra i 20 e i 30 anni. Sul fronte italiano si contano 650.000 caduti: mezzo milione perì al fronte (di cui 100.000 per malattia); 100.000 in prigionia e 50.000 morirono dopo la fine del conflitto a causa delle ferite riportate in combattimento.
10 milioni di uomini feriti o mutilati, una marea umana a cui si doveva aggiungere l’incalcolabile numero di civili feriti o malati a seguito di bombardamenti, occupazioni e sfollamenti. Ed è proprio su questi indelebili segni lasciati dal conflitto sulla popolazione europea, uomini e donne, su cui vorrei concentrare l’attenzione oggi perché la guerra non termina con la firma dell’armistizio; al contrario lascia tracce durature nella vita, nel corpo, nella mente di chi ha combattuto e di chi l’ha subita da civile.
Dopo quasi un anno di neutralità, il Regno d’Italia entrava in quella che sarebbe passata alla storia come la prima delle guerre totali del XX secolo, una guerra moderna, di massa, che ha spazzato via imperi ultracentenari e restituito un continente nel caos, terreno fertile per gli orrori che sarebbero giunti poco più di due decenni dopo con il secondo conflitto mondiale.
La guerra totale travolse ogni aspetto della società europea: l’economia e la produzione industriale si convertirono, politici e intellettuali si mobilitarono per spiegare le ragioni dell’intervento alla popolazione e gli uomini si prepararono alla possibilità di dover lasciare forse per sempre la propria casa. In questo contesto, il cosiddetto “fronte interno” divenne la spina dorsale del paese, la mobilitazione fu totale perché non furono più solo i soldati a essere coinvolti, ma tutta la popolazione fu chiamata al sacrificio per la Patria. Così i bambini a scuola impararono a conoscere le rivendicazioni nazionali su Trento e Trieste; le donne uscirono dalle loro case per andare in fabbrica, o ressero da sole il peso dei campi e degli allevamenti; medici, accademici, ingegneri furono chiamati a contribuire sia alla propaganda che all’avanzamento della tecnica.
Proprio richiamando questa dimensione totalizzante, oggi abbiamo il dovere di ricordare chi combatté, chi fu ferito o cadde indossando la divisa delle nostre forze armate, ma anche chi sostenne lo sforzo bellico con la propria resilienza giornaliera, in una profonda devozione rivolta prima di tutto agli uomini ormai lontani e solo secondariamente all’amor patrio.
Troppo a lungo la guerra è stata considerata “cosa da uomini”, per troppo tempo il contributo delle donne è rimasto in secondo piano, ma la storia della Grande Guerra è una storia totale, di un intero popolo, come lo è stato il conflitto, e unisce esperienze solo all’apparenza molto diverse. Quella che è spesso definita la “storia dal basso” racchiude il tassello d’unione tra le trincee e il fronte interno, tra l’esercito e la sua gente: le lettere spedite da una parte all’altra della penisola e i diari faticosamente compilati nei momenti di quiete sono un patrimonio storico senza eguali che permette di dare uno sguardo a quella che è stata la guerra delle persone.
La “guerra vissuta” è l’unica che conserva ancora il potere di avvicinare generazioni ormai lontane dal ’15-’18, di restituire la dimensione di una tragedia umana che i contemporanei speravano non si ripetesse mai più. È anche la guerra che non si è conclusa il 4 novembre 1918, ma ha continuato ad accompagnare i sopravvissuti per tutta la vita.
Quando i cannoni tacquero, le grida dell’umanità lacerata nelle carni e nella mente continuarono: proseguirono nelle corsie degli ospedali; nelle case di rieducazione per mutilati; nelle case prive del marito o del padre; nei paesi devastati; nei treni che rimpatriavano i profughi verso case ormai distrutte; negli orfanotrofi dove i figli del nemico o della vergogna venivano abbandonati.
La guerra era finita ma la pace per molti tardava ad arrivare. La guerra era finita, ma le officine protesiche continuarono a lavorare a pieno ritmo fino all’inizio degli anni ’20; era finita ma i manicomi italiani continuavano ad accogliere ex-soldati incapaci di convivere con gli orrori che avevano visto e compiuto, e donne la cui salute psicofisica era ormai compromessa a causa di privazioni e lutti. Quando ricordiamo la fine della Prima guerra mondiale dobbiamo, quindi, essere consapevoli che le guerre non finiscono col cessare dei combattimenti ma con l’elaborazione di una memoria condivisa, che consenta ai veterani e ai sopravvissuti civili di reinserirsi in una società consapevole dei loro sacrifici e delle loro fragilità.
Lo sforzo delle autorità sia civili che militari e dei professionisti della medicina per favorire il reintegro dei soldati invalidi nella società produttiva fu enorme. Le officine protesiche di Milano e Bologna, incaricate ufficialmente dal ministero, produssero poco meno di 10.000 protesi ciascuna, circa 15.000 calzature e oltre 6.000 apparecchi ortopedici tra il 1915 e il 1920. Numeri che ora appaiono come limitati ma che per l’epoca erano straordinari. Centinaia di case di rieducazione nacquero in tutta Italia con lo scopo di insegnare un mestiere ai reduci mutilati.
Più difficile fu accompagnare la popolazione nella presa di coscienza che il reinserimento, l’autonomia di questi uomini era cosa possibile e auspicabile, che l’invalidità non doveva necessariamente precludere lo sviluppo di una vita piena. Con la Grande Guerra, possiamo dire, iniziò anche una lenta modificazione culturale dell’approccio alle menomazioni fisiche, lenta perché l’impatto visivo e sociale dei segni guerreschi incisi sulla carne dei veterani erano sconvolgenti persino per i medici e i cappellani militari e rappresentavano un promemoria incompatibile con la spinta al futuro sempre più pressante dopo la fine del conflitto.
Portavano sul corpo deformato le stigmate delle loro sofferenze. Erano giovani, miserandi avanzi di umanità. La loro vita non era stroncata, ma ridotta e divenuta oggetto di commiserazione. A chi mancava un braccio, a chi un piede, a chi una gamba o tutte e due le gambe, chi invece di braccia aveva solo moncherini. Chi si trascinava con le grucce, e chi era trascinato dalle braccia, perché cieco. Tutti facevano pietà. E come se ciò non bastasse, erano così esasperati che non si riusciva mai a contenerli a pieno. Non vi meravigliate – mi disse una volta qualcuno di essi- se ci vedete così esasperati. Siamo dei poveri tronconi, dei poveri cenci umani, e così andremo alle nostre case.
Lo sconvolgimento, l’orrore, è trasmesso alle nostre generazioni attraverso scritti come questo del cappellano militare Carmine Cortese che scrive dalle trincee ma anche dalle cartelle cliniche che ancora giacciono negli archivi degli ospedali italiani. Alcune di queste pagine provengono direttamente dagli ospedali da campo e trasmettono tutta la frenesia del servizio sanitario di guerra attraverso la scrittura frettolosa dei medici, le sbavature dell’inchiostro che non c’era il tempo di lasciar asciugare, la consumazione della carta maneggiata, stropicciata e infilata nella barella del paziente per il trasferimento.
Qui troviamo Piero, diciottenne della provincia di Torino che il 19 giugno del 1916, durante un assalto vicino ad Asiago, venne colpito da un colpo di fucile al ginocchio sinistro, due colpi al gomito e al braccio destro con frattura dell’omero e paralisi del radiale. Giacque sul campo di battaglia, appiattito in una buca e circondato da cadaveri per 18 ore prima di essere raccolto. Il 30 giugno, dopo le prime cure negli ospedali da campo e di prima linea, giunse a Bologna dove subì l’amputazione della gamba dalla coscia in giù per via di un’infezione. Rimase ricoverato per oltre otto mesi prima di tornare a casa con una protesi e un braccio poco funzionante.
Accanto a quella di Piero, giacciono le storie dei soldati e di chi li curava, di quei medici militari o civili che convivevano tra il dovere verso il paziente e quello verso la patria, tra il dovere di curare e quello di rattoppare perché la guerra di massa, la guerra totale, è ingorda e ha bisogno di uomini. Così gli standard si abbassarono: se alla fine del XIX secolo sulle riviste militari si discute di criteri di riforma più stringenti per creare un esercito qualificato, composto solo dagli elementi più sani e resistenti, dal 1915 era sufficiente riuscire a reggere un fucile, non aver perso tutti i denti e poco altro. Era la realtà della nuova guerra a cui nessun esercito europeo era preparato.
E nessuno era preparato nemmeno all’impatto che le nuove tecnologie avrebbero avuto sui corpi e sulle menti dei soldati. I comandi e gli psichiatri militari accolsero perplessi e sospettosi le svariate decine di soldati che nei mesi successivi allo scoppio del conflitto cominciarono a manifestare diverse forme di disagio psichico. Come scrisse Eric Leed, uno dei maggiori storici del XX secolo e autore di “Terra di nessuno” che ha cambiato il nostro modo di analizzare la Grande Guerra, le nevrosi di guerra furono un effetto non tanto della guerra in generale, quanto della guerra industrializzata in particolare. La Prima guerra mondiale passò, infatti, alla storia della medicina come la “guerra dei nervi”. L’impatto sensoriale e distruttivo delle nuove tecnologie, sommato al logoramento della guerra di posizione conduceva ai crolli nervosi.
L’immobilità era l’attesa del momento in cui una granata sarebbe caduta nella propria trincea, il tempo era scandito da quanti secondi mancavano al bombardamento successivo e quando questo arrivava la casualità con cui troncava le vite era soverchiante. La guerra totale era tale anche in trincea perché attraverso la sua violenza coglieva tutti indiscriminatamente. Così il soldato si rifugiava in sé stesso, escludendo il mondo e rimanendo insensibile agli stimoli, in una catatonia che a volte non ammetteva nemmeno la commozione per una madre rivista dopo anni di lontananza. Oppure, al contrario, reagiva esageratamente a ogni stimolo che gli ricordava la guerra come un rumore forte o la vista di un uniforme.
Gli eserciti e la medicina europei reagirono diversamente all’altissimo numero di quello oggi chiamiamo comunemente stress post-traumatico ma ovunque questi soldati furono accompagnate dallo stigma della codardia e sospettati di simulare la propria condizione. Dopo la guerra, il Regno d’Italia concesse la pensione solo a un sesto dei richiedenti per malattia mentale.
Ricordando oggi con gratitudine chi è caduto per l’Italia e facendo memoria di quanto accadde riprendo le parole di un recente discorso del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
"Il riconoscersi tra i popoli come eguali, gli scambi, il permettere accesso reciproco alle rispettive risorse, ha sconfitto, nel Novecento, l’idea che, per sopravvivere, fosse necessario combattere per sottrarre beni a qualcun altro. Il nazionalismo da opporre ad altri nazionalismi nasce dal considerare gli altri popoli come nemici, se non come presenze abusive o addirittura inferiori per affermare con la prepotenza e, sovente, con la violenza, pretese di dominio.
Per un trentennio tutto questo sembrava avviato ad essere archiviato nel passato… Oggi ci confrontiamo con uno scenario molto diverso, anche in Europa. Il tema della forza pretende nuovamente di essere misura delle relazioni internazionali. Abbiamo costruito, con l’Unione Europea, una condizione - sin qui realizzatasi tra i suoi membri - per cui le armi avrebbero taciuto per sempre".
Le sue parole sono anche il mio auspicio.
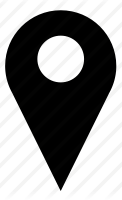 CUNEO
CUNEO cuneo
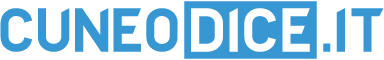

 Condividi
Condividi