Roghi senza fiamme: il paradosso della censura nel ventennio fascista
A Dronero il dialogo con Anna Ferrando: "I libri stranieri nel regime erano più diffusi. Il corto circuito? Chi venne censurato trovò grande fortuna nel dopoguerra"La censura, un argomento antico, recente e quanto mai attuale. Nel dizionario Treccani il significato che vi si trova è il seguente: "Esame, da parte dell’autorità pubblica (c. politica) o dell’autorità ecclesiastica (c. ecclesiastica), degli scritti o giornali da stamparsi, dei manifesti o avvisi da affiggere in pubblico, delle opere teatrali o pellicole da rappresentare e sim., che ha lo scopo di permetterne o vietarne la pubblicazione, l’affissione, la rappresentazione, ecc., secondo che rispondano o no alle leggi o ad altre prescrizioni". Tipico dei governi di stampo autoritario, non si tratta di un qualcosa cronologicamente arretrato, come molti possono erroneamente pensare. È un argomento quanto mai attuale.
Un tema che è stato approfondito nella penultima serata di Ponte del Dialogo di Dronero grazie all'intervento di Anna Ferrando, professoressa presso l'Università di Pavia e originaria della zona dronerese. Un viaggio che ha una sua collocazione temporale ben precisa, quello del ventennio fascista, dal titolo: "Roghi senza fiamme. Censura, libri stranieri e autori ebrei nel ventennio fascista".
"A me piace guardare la storia dei libri per guardare al contesto storico e capirne la sua evoluzione", inizia così il viaggio temporale di Anna Ferrando, facendo riferimento a Fahrenheit 451 di
L'Italia fascista: quante traduzioni, invasa dallo straniero
A sopresa, l'Italia del regime fascista era una delle nazioni che traduceva più libri. Ma perché la traduzione può essere interessante? "Cesare Pavese individua tre punti: valenza sociale, culturale e politica. La prima consente di allargare lo spazio della cultura in quegli anni. Il secondo perché tradurre in testo straniero vuol dire essere al corrente con i tempi e con le correnti del pensiero internazionale. Il terzo perché negli anni trenta, quello che viene chiamato decennio delle traduzioni, esse sono il primo vero spiraglio di libertà. Che tutto non finisse con la cultura dei fasci".
Anna Ferrando si concentra sulla valenza politica, soffermandosi sulla traduzione italiana del Mein Kampf di Hitler. In Italia il volume fu pubblicato nel 1934 e poi nuovamente nel 1938, su richiesta dello stesso Führer a Mussolini, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la campagna elettorale del 1933, che lo avrebbe portato a diventare Cancelliere del Terzo Reich. Anche in Inghilterra c'è un caso editoriale, come il caso Beveridge, nato come contrasto alla rappresentazione del nazionasocialismo come esempio di stati protettori.
Una contraddizione: l'Italia fasciata che traduce grandi quantità di libri stranieri. Si parla di un rogo di libri addirittura nel 1938 nei diari di Galeazzo Ciano. "Iniziava a circolare la percezione di un'Italia fascista invasa dallo straniero in termini culturali". Quel rogo non ci sarà mai, ma questo dettaglio stona con la cultura "conquistatrice" che si voleva per il fascismo.
Effettivamente, l’Italia fascista era il più grande consumatore di libri tradotti al mondo. Gli editori si difendevano sostenendo che i libri stranieri vendevano di più e costavano di meno. Un esempio lampante è la collana di libri gialli lanciata da Mondadori nel 1929: alla prima tiratura vendevano 20.000 copie, alla seconda 10.000, mentre gli autori italiani arrivavano al massimo a 5.000 copie.

Una vera e propria campagna anti traduzione
Italia e Germania faranno un accordo nel '38: i romanzi invisi al nazismo non devono circolare nella penisola. Cosa che prima era successa, dato che erano tantissimi i libri di autori ebrei ad aver trovato spazio nel suolo italico. La differenza tra i due Stati però si trova a livello di esportazione: i teutonici riescono ad esportare tantissimo, cosa che l'Italia non riusciva a fare a livello di libri.
Così parte una vera e propria campagna diffamatoria nei confronti delle traduzioni. Nel 1934 avviene la prima, più di natura sindacale, mentre quella del 1938 sarà marcatamente xenofoba.
Il primo provvedimento contro le traduzioni arriva nel 1937: tutti gli editori avrebbero dovuto avvisare Roma ogni volta che avrebbero avuto l'intenzione di tradurre un libro. Non mancheranno i bavagli agli editori antifascisti, come Gobetti, Monanni e Dall'Oglio. "La censura come pedagogia, come punto per osservare la costruzione di un'identità fascista inizia attaccando l'antifascisimo. E prosegue anche con la letteratura che non è politica". Il disciplinamento delle menti non riguarderà solo le traduzioni, ma comprenderà anche sessualità e musica, come il jazz.
Ovviamente però tutto questo porterà ad un vero e proprio corto circuito.
Il rovescio della medaglia
Una macchina del genere porta però inevitabilmente al rovescio della medaglia. Prendiamo come esempio il romanzo "Their Eyes Were Watching God" di Zora Neale Hurston tradotto nel 1938 da Frassinelli. Perché? "Sono i corto circuiti della censura. Perché anche gli USA hanno le loro contraddizioni, perché anche loro hanno i problemi interni. Questo romanzo sarà letto tantissimo nel dopoguerra, anche scrittori come Pavese lo usreanno per spingere i processi di riforma". Tanti testi di afroamericani veranno tradotti in quegli anni.
"Gli effetti imprevisti? Il fascino del proibito ha sempre il fascino del proibito. E quei testi che erano stati censurati in quel periodo dell'Italia fascista spesso conosceranno una grande fortuna nell'Italia liberata, democratica".
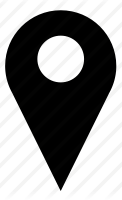 DRONERO
DRONERO Anna - Ponte del dialogo - ferrando - roghi senza fiamme
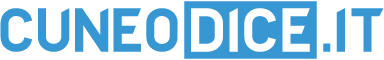




 Condividi
Condividi