La ricchezza dell’arte cuneese
Un viaggio attraverso i secoli che, dal Romanico al Contemporaneo, racconta un territorio attraverso forme e coloriLe terre della provincia di Cuneo si distinguono per i loro paesaggi, le vallate, i borghi antichi e per il loro passato. Credenze, tradizioni popolari, dialetti, festività e gastronomia rivelano la profondità di una cultura che ha attraversato i secoli, lasciando testimonianze fino al giorno d'oggi. Importantissime per descrivere la storia di un territorio sono anche le opere a cielo aperto, gli affreschi e le sculture conservate nei musei, nei palazzi storici o nelle chiese. Osservando tutta l'arte che il cuneese offre si può scoprire un viaggio che racconta come in un'unica provincia si siano susseguiti e incontrati stili, idee e generazioni di artisti, che tutte insieme definiscono il cuore culturale di quest’area.
Nei primi secoli del secondo millennio, grazie all'affermazione tardiva del Cristianesimo fu possibile una svolta architettonica e artistica, nella quale fu il Romanico a imporsi. Vennero così costruiti a partire dal nulla o sulla base di precedenti strutture numerosi conventi e santuari, molti dei quali, però, furono distrutti a seguito delle invasioni saracene.
Le testimonianze di questo periodo storico e artistico sono ancora visibili a Borgo San Dalmazzo, all'interno dell'antica Chiesa Parrocchiale dei santi Filippo e Giacomo di Verzuolo, che custodisce diverse opere del XIV e XV secolo pur essendo in realtà stata edificata solo nel ‘700, e a Villar San Costanzo, dove l'architettura e le arti figurative di alcuni edifici rappresentano le diverse sfaccettature del Romanico. San Costanzo al Monte inoltre è un esempio lampante di un’antica costruzione che rappresenta al meglio lo stile artistico con una cripta composta da archi e capitelli tipici del tempo. Infine l'Abbazia dei santi Pietro e Colombano, situata in valle Bronda a Pagno, si distingueva per il suo interno romanico, completamente decorato con affreschi e pavimenti a mosaico nella zona presbiteriale, purtroppo andati in gran parte persi dopo le ristrutturazioni del XVIII secolo che hanno provocato l'abbattimento delle absidi.
Sul finire del Medioevo, al Romanico si affiancarono elementi gotici. Tra grandi costruzioni e piccole strutture isolate, la Granda si vestì di una nuova identità artistica, capace di offrire luoghi di rifugio per tutti i fedeli. Nell’Abbazia di Staffarda, fondata a partire dal quarto decennio del XII secolo da monaci cistercensi, vennero aggiunti diversi tratti gotici alla struttura esistente, creando un mix stilistico affascinante. Il Gotico “primitivo” emerge nella Chiesa di San Francesco a Cuneo originaria del XIII secolo, mentre quella di San Giovanni a Saluzzo risale alla metà del XIV secolo; in generale, sono poche le composizioni che si possono collocare al periodo in cui si stava andando a esaurire anche l'ultima stagione del Gotico europeo, noto come “internazionale” o “fiorito”. Il XV secolo fu caratterizzato da un'ulteriore rilettura, con una rinascita degli edifici, come per le chiese dedicate all'Assunta di Rossana, Revello e Saluzzo, che diventarono più maestose, con ampie facciate caratterizzate da sculture, lesene e portali isolati.
Anche la pittura conobbe un momento di rilievo quando tra il Quattro e il Cinquecento cicli della passione e vite di santi iniziarono a essere raffigurati nelle chiese locali, con figure, abiti e paesaggi tratti dalla realtà territoriale d'epoca. A spiccare sono soprattutto gli affreschi nella parrocchiale di Elva, opera del pittore fiammingo Hans Clemer, e quelli della cappella cimiteriale di San Fiorenzo a Bastia Mondovì. Non meno significative sono le architetture neogotiche; tra le più rilevanti figurano i castelli di Racconigi, Pollenzo, Busca, Novello, Envie e Marene, il cimitero di Dogliani, oltre a un numero molto ampio di chiese, ville, parchi e giardini sparsi in tutto il territorio cuneese. Espansione stilistica di un gusto tardivo e reinterpretato, queste creazioni testimoniano la rinascita dell’immaginario medievale avvenuta nel cuore del Settecento, in parallelo al Gotico letterario inglese.
La cultura artistica della provincia non si esaurì nel Medioevo, in quanto fu infatti durante il Barocco che vennero alla luce costruzioni del tutto rinnovate come la Chiesa della Missione a Mondovì. Tra Sei e Settecento, l’equilibrio rinascimentale in Piemonte cedette il passo al dinamismo, alla teatralità, e alla spettacolarità del nuovo periodo culturale, reso ancora più drammatico dal realismo caravaggesco. Un esempio di questa tecnica pittorica la si ritrova nelle opere del pittore saviglianese Giovanni Antonio Molineri, che la introdusse nella sua patria dopo averla appresa durante un lungo soggiorno a Roma. Alla sua morte nel 1631, è il suo allievo Giovanni Claret a proseguire con questo stile; diverse loro opere sono ora custodite nella Chiesa di Santa Maria della Pieve di Savigliano.
Nella seconda metà del Seicento il Barocco si affermò nell’area cuneese in tutta la sua magnificenza. Stucchi, decorazioni, giochi prospettici, cromatismi, spazi illusori e fastosi diventarono centrali nei progetti di Francesco Gallo. Di particolare rilievo è la splendida cupola ellittica del Santuario di Vicoforte, la più grande del mondo in muratura, diventata infatti simbolo di questa stagione artistica; all’interno del capolavoro ingegneristico si sviluppano i 6.000 metri quadri dell’affresco, frutto della maestria di Mattia Bortoloni e Felice Biella.
Dalla metà dell’Ottocento, lo stile impressionista introdusse un’arte che privilegiava il racconto in colore e forme della realtà, muovendosi progressivamente verso la modernità. Nella provincia le opere si fecero voce della società, lasciando spazio alla rappresentazione della natura e del territorio. L'innovazione è diventata così la chiave di lettura dell'Arte Moderna e Contemporanea. La ricerca di forme espressive e lo spirito innovativo caratterizzano fin da metà ‘800 la produzione artistica.
A Racconigi una Pinacoteca è dedicata all'artista Carlo Sismonda, classe 1929, che affascinato dai pittori del XIX e del XX secolo, ha esplorato nel corso della sua vita visioni espressioniste, privilegiate da colori forti e contrastanti. Quarantasette delle sue opere, soprattutto dedicate al mondo della religione, sono custodite nella Torre San Giorgio. Savigliano rende omaggio invece a Davide Calandra con una Gipsoteca nel Museo civico “Antonino Olmo”, dove sculture, tele e mobili degli anni ’60-’70 convivono. A Dronero, il Museo Luigi Mallé espone diverse opere che spaziano dal tardo Cinquecento al contemporaneo, tra cui quelle dei paesaggisti Camino, Calderini, Van Elven e Avondo.
A Cuneo la Fondazione Peano ospita un giardino museale, dove l’arte contemporanea trova spazio all’aperto. Ogni anno, attraverso il concorso internazionale “Scultura da Vivere”, allievi di licei artistici, istituti d’arte e accademie possono vedere le proprie opere installate negli spazi verdi della città. Si tratta di un’iniziativa che valorizza la creatività giovanile e arricchisce il paesaggio urbano con sculture sempre nuove.
Dalle grandi chiese romaniche alle eleganti forme gotiche, dal fervore barocco alle espressioni impressioniste, il patrimonio artistico della Granda è ancora oggi caratterizzato dalla creatività che nei secoli ha caratterizzato il territorio, rendendolo custode di un’eredità unica fatta di originalità, creatività, storia, cultura e innovazione.
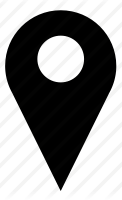 CUNEO
CUNEO arte
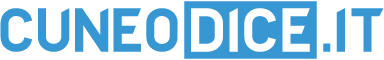

 Condividi
Condividi