Cultura, Cesare Pavese e l'illusione di una "bella estate"
L’esperienza dell’autore santostefanese porta con sé temi di assoluta modernità, che fanno di lui uno degli scrittori più amatiStar internazionale, testimone di un’epoca, idolo di generazioni e, ancora oggi, di molti giovani, Cesare Pavese è sicuramente uno degli scrittori più famosi di tutta la letteratura italiana e, insieme a Beppe Fenoglio, voce delle Langhe.
Conobbi Pavese al termine del quarto anno di liceo, in seguito al quale, durante le consuete vacanze estive, ci fu assegnata la lettura de “La luna e i falò”. L’incontro con il poeta di Santo Stefano Belbo fu dirompente: le parole di Pavese, entrando per la prima volta dentro la mia vita, si rispecchiavano con una stagione costellata di domande, dubbi esistenziali e attesa di una serenità sempre lontana.
“Non chiedevo la pace del mondo, chiedevo la mia” (La casa in collina). In particolare, dalla lettura de “La luna e i falò”, colsi subito alcuni punti della lirica pavesiana: il senso della storia, l’eterno desiderio dell’uomo di tornare e il destino della solitudine.
Una storia tragica in cui entrano la morte e la disperazione, in cui i cambiamenti travolgono la fragile esistenza, una storia in cui il protagonista cerca, senza successo, di tornare ad un passato svanito per sempre. È un racconto di ricerca sofferta delle proprie radici e di un luogo in cui trovare la pace. “Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”.
La scoperta di uno dei capolavori di Pavese mi accompagnò alla maggiore età consapevole dei cambiamenti che il destino mi stava riservando. Nello stesso periodo lessi alcuni stralci de “I dialoghi con Leucò”, opera in cui l’autore abilmente rivisitò il mito greco in chiave moderna. Mi colpirono due dialoghi, quello di Odisseo con Calipso e quello di Orfeo con una Baccante.
Nel primo, sulla base del noto poema omerico, la ninfa e l’eroe di Itaca discutono sul senso del viaggio e della vita eterna: “Immortale è chi accetta l’istante. Chi non conosce più un domani”. Una ricetta sorprendente sull’orma del “Carpe diem” oraziano, ma con un elemento in più: è proprio il fatto che la vita la si possa perdere da un momento all’altro a renderla degna di essere vissuta. La vita eterna per Calipso diventa una sorta di maledizione, un infinito senza l’amore in totale solitudine.
I protagonisti sono così caratterizzati da un’estrema umanità, la ricerca del senso caratterizza entrambi e li rende simili nelle enormi diversità. Sembra addirittura che Pavese conferisse maggiore eroicità alla vita mortale rispetto a quella immortale: l’uomo supera gli dei poiché mette in palio la vita, tutto ciò che ha, sapendo di non avere altro che quella.
Nel secondo, che trae origine dalla tragica vicenda mitica di Orfeo ed Euridice, il disperato Orfeo tesse un dialogo con la Baccante - una delle donne che si riunivano per onorare Dioniso tramite rituali finalizzati ad ottenere il massimo del piacere - al termine del quale viene ucciso. Pavese, qui, supera ancora una volta il racconto originale, proponendo una nuova chiave di lettura: Orfeo lascia l’amata dopo il viaggio negli inferi volontariamente, poiché consapevole che la nuova vita l’avrebbe destinata ad una sofferenza terribile, avendo saputo ciò che le sarebbe aspettato di nuovo nel Tartaro. Orfeo si rese conto che “l’Euridice che ho pianto era una stagione della vita”. Torna così il tema prepotente del tempo che passa, inesorabile, rendendo vano ogni desiderio di ritorno alle felicità tramontate.
A fine ottobre dello scorso anno visitai il “Museo Pavesiano” a Santo Stefano Belbo, un salto in quell’angolo di Langa che ispirò così tanto Pavese. Con la lettura de “La bella estate”, infine, la complessità della vita giovanile viene fuori in tutta la sua spontaneità, rendendo Pavese uno scrittore particolarmente vicino anche ai ragazzi.
In questo ciclo, che vinse il Premio Strega nel 1950, poco prima che l’autore ponesse prematuramente fine alla propria esistenza, i temi della ricerca del piacere, dell’amore si fondono con toni cupi e sinistri, con “la campagna nera”, con “le colline nere”. Si delinea un ciclo della vita umana che ha sempre caratterizzato la storia (“Queste notti moderne sono vecchie come il mondo”), teso tra la ricerca di un piacere sempre lontano e irraggiungibile, e l’aspettativa di una bella estate che, forse, mai arriverà.
Federico Mellano
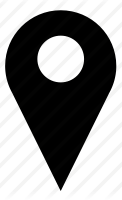 SANTO STEFANO BELBO
SANTO STEFANO BELBO Federico Mellano
commenti
Effettua il login per commentare
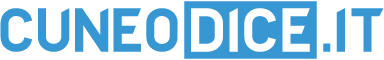

 Condividi
Condividi